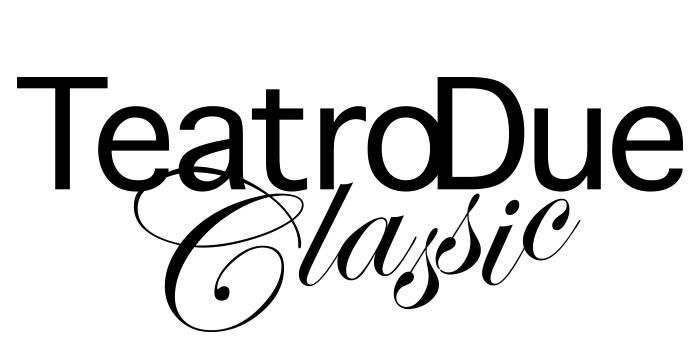London International Festival of Theatre
Shakespeare Symposium
21 agosto 1983
COLLETTIVO Oggi la gente va a teatro, si siede e osserva l’oggetto – spettacolo e subito comincia a interrogarsi sul significato degli elementi che lo compongono, oppure confronta quello che vede con un modello già esistente nella sua cultura, nella sua memoria.
Il critico prende questo oggetto e lo analizza, lo strutturalista lo destruttura.
Questo modo di fare nasce dall’abitudine della nostra società ai mezzi di comunicazione di massa, che producono oggetti finiti, compiuti, e a loro modo perfetti.
Questi oggetti si possono dunque analizzare, destrutturare e studiare nel loro significato.
Per noi, il teatro non è questo.
Per noi, il teatro è l’ultima occasione che la nostra società ha di creare un momento di incontro fisico, materiale e concreto tra individui, tra persone, in un contesto sociale e non in rapporto individuale.
Il teatro è un contesto in cui l’attore compie un’ esperienza e gli altri partecipano della stessa esperienza. Quello che lui fa, significa solo l’esperienza che sta compiendo ed è su quella che il pubblico si confronta.
Il teatro è l’ultimo spazio della conflittualità, non solo quella del contenuto interno all’opera, ma anche quella dell’attore come persona e come personaggio. Come persona è uguale al pubblico, come personaggio appartiene a un mondo diverso che si crea nel momento stesso in cui il pubblico accetta di essere in teatro.
Allora, il teatro è un momento che va colto in modo complessivo, è un sistema in cui sono indispensabili le due parti: chi fa e chi assiste, in cui il pubblico è l’altra metà del cielo e fa parte lui stesso della parola e del termine “Teatro”. Esso non è un elemento esterno che osserva un oggetto.
Perciò tutte le volte che facciamo teatro, noi viviamo un’esperienza. Non affermiamo questo in senso romantico, ma proprio in senso anche strettamente biologico, perché nella nostra vita di tutti i giorni molte ore le spendiamo in teatro, noi stiamo vivendo veramente quando recitiamo.
Viviamo in modo particolare in un modo che può essere più o meno affascinante. E il pubblico ci guarda vivere. Ma, come nella vita esistono delle ragioni storiche, sentimentali, politiche che spiegano le nostre azioni, sulla scena c’è qualche cosa che sta dietro le nostre azioni e noi abbiamo scelto che questo “qualcosa” sia Shakespeare. Qui sta la molla delle azioni che noi compiamo e il conflitto è tra noi e Shakespeare. Ma Shakespeare è lontano, Shakespeare è morto: è lontano nello spazio e nel tempo. Noi invece siamo presenti. Noi vorremmo essere come la poesia di Shakespeare ma viviamo in un’epoca in cui quella poesia si degrada, in cui i sentimenti vivono nella indifferenza e fra noi e Shakespeare si crea un conflitto reale, e, nel tentativo di superare questo conflitto, si crea la materia del nostro teatro.
A volte troviamo delle coincidenze con Shakespeare a volte invece abbiamo delle discrepanze e questi incontri e queste discrepanze sono la materia poetica del nostro teatro. Tutto il nostro lavoro di attori sta nel far scaturire, con estrema onestà ed estrema coscienza di noi stessi come individui sociali vivi nel presente e con una conoscenza letteraria di Shakespeare il più approfondita possibile, queste discrepanze e queste coincidenze.
Perché proprio Shakespeare? Perché in Italia non esiste una letteratura teatrale nazionale e non esiste una lingua nazionale teatrale. Ciò ovviamente per ragioni storiche. Non esiste una lingua che possa rappresentare con estrema chiarezza i nostri problemi, come invece esiste in Germania, Francia, Inghilterra. Noi non ci sentiamo rappresentati da una letteratura, e questo si coglie nella radice della nostra tradizione teatrale. Quando in Europa si scrivevano testi con una coscienza e una lingua nazionali, in Italia il teatro, lottava per sopravvivere. Quindi l’attenzione del teatro si è concentrata di più sulla presenza dell’attore che non sulla lingua. Questi attori però non erano incolti, anzi, si creavano una lingua “saccheggiando”.
Allo stesso modo, noi oggi stiamo saccheggiando Shakespeare.
Quindi la poesia di Shakespeare può servire a noi, ma noi, nella nostra lingua, ben difficilmente potremo restituire lo stesso sapore della poesia letteraria.
D’altra parte io temo che non si possa più riprodurre sulla scena la poesia letteraria e questa poesia serve a noi per trovare le ragioni di un’esperienza compiuta nell’ultimo contesto sociale che ci è rimasto: il teatro.
JOHN RETALLACK […] Tutti gli attori in scena davano l’impressione di avere una idea precisa di quello che stavano facendo e, soprattutto, di capirsi reciprocamente a fondo. Per me è stata una grande novità, sono rimasto estremamente sorpreso nel vedere una cosa del genere.
Assistere a questa maniera di essere un ensemble di attori, è stato molto più di uno shock. Era come se Amleto fosse diretto dal di dentro, non ho mai visto niente di simile.
È sicuramente la cosa più magica che mi sia mai capitato di vedere.
Il loro linguaggio teatrale è sorprendente: il modo in cui si muovono sulla scena, questo negare l’illusionismo scenico, il sapere dove si trova l’altro in ogni momento, così come le loro continue azioni: l’attraversare, il salire o scendere il palcoscenico.
TERRY HANDS: In qualità di regista professionista, mi è capitato di allestire Amleto e devo dire che è stata una responsabilità ed è stato difficile arrivare al successo.
Vado sempre a vedere allestimenti di Shakespeare quando vengono presentati a Londra. Ma spesso le rappresentazioni mi mettono a disagio.
Io penso che il Collettivo sia ancora, e in continua, fase di crescita: dopo Amleto nutrivo delle riserve, dopo Macbeth la mia curiosità era al massimo grado, quando ho visto Enrico IV sono stato immensamente impressionato e mi sono detto: “è la migliore opera presente a Londra in questo momento, senza ombra di dubbio.”
PETER CONRAD – Come prima cosa analizzerei l’atto di scherzare sulla frase “Essere o non essere”. “Essere o non essere”, come appare nella rappresentazione è già uno scherzo, è un’evasione, una grande deviazione metafisica dal bisogno di recitare un’azione specifica che Amleto non ha voglia di recitare e che sfugge generalizzando la faccenda con la sua tecnica meravigliosa e originale la quale non fa altro che esaminare il significato universale di una cosa che è abbastanza semplice e specifica. Perciò quello che sto dicendo è che “Essere o non essere” è già uno scherzo, e che la Compagnia non ha fatto nulla che Shakespeare non contenesse già.
A ciò si aggiunga l’osservazione che, mentre facciamo di Shakespeare una comodità, esso si consuma sempre di più. Ebbene, Shakespeare è un buon esempio di una rappresentazione consumata nel momento in cui Shakespeare la scrisse, consumata fin dall’inizio perché è un adattamento che possiamo forse presumere che a Shakespeare fosse imposto. Una rappresentazione rozza di crudele riuscita, una rappresentazione di sangue.
GIGI DALL’AGLIO – I nostri spettacoli, chiunque sia l’autore, sono autobiografici perché in scena ci siamo noi, e noi crediamo che la realtà da un punto di vista ideologico si muova o il suo movimento si possa spiegare attraverso la dialettica, per esempio la nostra personale esperienza politica e ideologica ha attraversato tre momenti che corrispondono a un movimento di bisogno dialettico che per noi corrispondono alla scelta dei tre testi di Shakespeare.
Abbiamo vissuto un’esperienza politica in cui si pensava che, con la parola, si potessero spiegare o trovare le ragioni per agire ed era il periodo in cui si pensava, in Italia e non solo in Italia, che con la parola si potesse cambiare il mondo. Parlo di quindici anni fa.
Il nostro modo di intendere l’Amleto, è la memoria malinconica di quel tempo in cui credevamo che il teatro avesse una capacità didattica di comunicazione; ma proprio l’esperienza su Shakespeare ci ha fatto scoprire la frustrazione di questo atteggiamento perché appunto, anche nel contesto dell’opera, è frustrata questa speranza della ragione.
Il nostro “Amleto” è il primo punto di un movimento dialettico: è la “nostalgia della dialettica” perché finisce con la crisi di questa dialettica. Alla crisi di questa speranza corrisponde un momento di cinismo che nella storia del nostro Paese assume un aspetto di forte negazione. Alla speranza di cambiare il mondo con la parola, si sostituisce quella di cambiare il mondo con un’azione.
Caso mai appoggiando quell’azione a qualche slogan ideologico.
Questo è Macbeth che non ragiona sulle azioni, ma le compie appoggiandosi a una falsa profezia.
Questi sono in Italia gli anni di piombo, gli anni di chi compiva azioni partendo da una “profezia” scritta, mentre attorno a lui il mondo colpito dalla violenza da ogni parte cadeva nell’indifferenza più assoluta e ogni gesto che voleva diventare eroico o santo rischiava di diventare solo una tragica gaffe.
L’unica tragedia del nostro Macbeth è, nei nostri giorni, l’assenza della possibilità della tragedia, è l’assenza totale del pathos, è l’assimilazione della violenza come gesto primitivo, è l’abitudine alla violenza che diventa indifferenza.
Niente si spiega, tutto è. Quando le streghe nel nostro Macbeth mostrano il trono e Macbeth chiede che cosa significhi, la strega risponde: significa una sedia. Questo è il “Macbeth” : qui il gesto non ha conseguenze, il gesto è privo di significato storico.
Questa è “Assenza nella violenza” e, nel movimento della dialettica, rappresenta l’antitesi.
Facendo il “Macbeth” l’impossibilità della comunicazione è diventata un fatto reale anche per noi. Nel nostro “Macbeth” c’è una fuga dalle azioni di violenza, dalle azioni patetiche, e noi in scena riconosciamo una sorta d’impotenza reale alla rappresentazione: tutto quello che si rappresenta siamo noi stessi con quel fondo di indifferenza che ci accompagna e con i nostri umori e odori corporali.
Quando si arriva a questo punto, o si smette di rappresentare, o si smette di vivere o si sceglie qualche altra cosa. E noi abbiamo scelto nell’Enrico IV di guardare la realtà così come essa è, con le sue contraddizioni e così in noi abbiamo scoperto due nature, da un lato abbiamo ancora una spinta politica che si potrebbe investire in azioni di potere politico spregiudicate, dall’altra c’è in noi una sorta di utopia di poter portare avanti la nostra vita sempre giocando e poiché siamo attori, giocando vuol dire facendo sempre teatro.
Ed ecco Falstaff e Enrico. Ma il nostro Falstaff preso da questa infantile utopia non si accorge che i tempi cambiano ed è su questo problema che noi compiamo il terzo movimento dialettico, quello della sintesi in cui bisogna sapere unire una concezione ludica della vita con una capacità (ambizione) politica dell’agire. Al nostro Falstaff va tutta la nostra simpatia, ma non va il nostro rispetto sul piano della scelta di vita. E noi abbiamo fatto questo capovolgendo il rapporto: la realtà è storia e quindi rappresentazione. La corte è sempre rappresentazione, sintesi. Il gioco è la vita (in tutti i sensi) e noi giochiamo due ore a vivere con Falstaff e i suoi amici mentre dietro di noi la storia avanza.
Questa è una sintesi un po’ sbrigativa delle linee generali dei nostri spettacoli e anche della nostra vita.